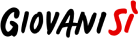Gran Magal
Paolo
I senegalesi sono nati tutti il primo di gennaio, e Manlio pensa che non ho mai da fare un cazzo. Arriva e mi trova davanti al computer, ha quel suo modo di guardarmi, come se mi trovassi qui al Samarcanda a rubare il rimborso spese. Manlio butta qua un “Buongiorno” strascicato, che mi suona come una specie di “Hai visto un bel mondo, bimbo”. «Buongiorno», rispondo io tenendo gli occhi sullo schermo del computer.
Manlio si toglie giacca e cappello, li sistema sull’attaccapanni dandosi le arie di un guerriero che rientra or ora da uno scontro con i mercenari di una banda. Perché Manlio mica è come me. Sta sul campo di battaglia, lui. Affronta i nemici a viso aperto. Mentre io sono solo un volontario che si diverte a sprecare i pomeriggi davanti al computer dell’associazione.
Eppure provo a ripetermelo: non è colpa sua. Manlio ha l’età che ha. Se provassi a spiegargli cos’è un ufficio stampa, se ne starebbe qui a guardarmi con occhi grandi, dondolando appena la testa. Lo spio alle mie spalle dal riflesso. Manlio prende su le circolari, legge. Ha quel suo tic odioso. Un modo di tirare costantemente su con il naso, senza motivo e a ripetizione. È una cosa che mi prende allo stomaco. Quindi lo vedo farsi avanti con i gomiti sulla scrivania. «Catone», fa. «Bisogna chiedere gli spazi per…»
«Fatto», dico senza neanche voltarmi. «Sto buttando giù la locandina».
Alle mie spalle, il silenzio. Poi, con un soffio di voce: «Ah, la locandina…». Dal riflesso lo vedo scuotere d’un niente la testa.
Manlio ha questo problema inesorabile: secondo lui, tutto quello che viene fatto attraverso un computer non è degno di essere chiamato “lavoro”. Non ha la più pallida idea di cosa significhi tenere attive le informazioni della pagina facebook del Samarcanda. Se dico di dover implementare dei documenti sul sito dell’associazione, lui commenta con un “Mmm” disarmato. Peggio se pronuncio parole come “newsletter”, “download”. Persino la parola “file” la tollera poco. Un giorno gli ho proposto di aggiornare il logo di Samarcanda, e lui mi ha risposto così: «E secondo te dove ne troviamo un altro? Già quelli dell’ARCI Caccia si sono presi i due stanzoni qui accanto, tirando su un muro di compensato».
Va sempre a finire che oltre a tenere in piedi la comunicazione, debba costantemente far fronte a tutta una serie di incarichi che neanche mi riguardano. Tra questi, l’accoglienza allo sportello.
«Con chi hai parlato?», sento dire da dietro.
«Donatella, del gruppo Taglio e Cucito. Dicono che per loro va bene, ma bisogna che la stanza sia lasciata com’è adesso. E non si deve toccare niente dallo sgabuzzino».
Dal riflesso dello schermo guardo Manlio restare un attimo sospeso a pensare. Poi butta un grosso respiro. «Speriamo bene», dice. Quindi abbassa gli occhi sui fogli alla sua destra. E io mi sento bruciare dentro.
In fondo non è colpa mia, ma nel silenzio che segue sento il cuore accelerare lo stesso. Finché ecco l’inevitabile: «Scusa una cosa», fa Manlio. Smetto di ritagliare la forma che ho davanti. Ma ancora non mi volto. Dico: «Sì».
Manlio adesso sta passando con lo sguardo tutte le carte, una dopo l’altra. Arriva all’ultima. Dal riflesso lo vedo lasciarle andare sul piano in malo modo. Sbuffa: «Non mi posso allontanare un minuto e…». Abbandono il mouse. Solo a questo punto mi volto a guardarlo.
«Senti, lo sai come funziona», dico.
Manlio sperde per un momento lo sguardo nel vuoto. Tiene su una specie di sorrisetto ironico e amaro insieme. «Certo che lo so. E so anche che ci sono delle procedure da seguire. Ma evidentemente…».
«Evidentemente non servono a niente. Quelli si presentano qui con un documento. Sul documento c’è scritto giorno e luogo di nascita. Stop».
Manlio sospira ancora, quindi indica le carte con un colpo di mento. «Guarda caso gli ultimi sei sono tutti nati a Dakar, il primo di gennaio. Quattro, persino nello stesso anno. Famiglie belle larghe, eh?».
Liquido questa polemica inutile tornando a guardare lo schermo.
Come se Manlio non sapesse che per Samarcanda è impossibile risalire all’autenticità di un documento. E nove su dieci, anche per la polizia. I senegalesi non sono come noi. Tra quelli che arrivano al nostro sportello ce ne sono alcuni che un bel giorno si sono presentati in chissà quale ufficio in terra d’Africa, buttando là giorno, mese e anno di nascita. Di solito scelgono la prima casella del calendario. E Dakar è la città più conosciuta, anche l’ultimo contadino sa dire il nome della capitale. Così accade sempre più spesso di trovarsi al cospetto di un Abiba e un Amir nati il primo giorno dello stesso anno. Nonostante uno abbia già i peli sulla faccia, e l’altro no. Comunque per noi è l’ultimo dei problemi. E di sicuro anche per loro.
Concludo la bozza della locandina, lancio la stampa in bassa risoluzione. Prendo in mano il foglio, faccio un respiro. Quindi mi volto, raggiungo il mio responsabile. Glielo metto davanti dicendo: «Se va bene, la mando a stampare in grande».
Manlio ha l’abitudine di tenere gli occhiali in punta di naso. Afferra il foglio da un angolo, con due dita, come se si trattasse della carcassa di un topo. Lo osserva inarcando le sopracciglia. Alla fine annuisce, senza spiccicare mezza parola. E si tira indietro, per farmi capire che posso raccogliere quella roba per portarla via dalla sua scrivania.
Me lo chiedo ormai da sette mesi e ancora non ne vengo a capo: cos’è che muove un orso dello stampo di Manlio Buselli a un’attività come la nostra. Si sfonda di turni alla Lucchini e dopo si fionda qui, come se neanche avesse una famiglia, inzuppandosi fin sopra i capelli nei problemi di ucraini, pakistani, albanesi, rumeni. Senegalesi. Si accerta che tutti gli uffici d’accoglienza e orientamento per gli extracomunitari facciano il loro lavoro. Sorrido tra me ripensando alla parola “uffici”: un eufemismo. Mentre salvo il pdf in alta risoluzione della locandina continuo a farmi la stessa domanda: non sarebbe meglio starsene a casa con la propria moglie invece d’infettare l’esistenza a uno come me, per esempio? Senza considerare gli sbattimenti nei casi limite dei clandestini e dei violenti ubriachi.
Accedo alla casella di posta del Samarcanda, invio il file alla tipografia. Insieme, ne approfitto per leggere i nuovi messaggi. Ce n’è uno.
«Hanno trovato un Capocasa in via dell’Unità», dico dopo un po’. Manlio alza la testa dalle scartoffie.
«Come?».
«Via dell’Unità», ripeto.
«Un Capocasa. Al diciannove».
A quanto ne so, il Capocasa è la massima infrazione in cui possa incorrere un senegalese. Possono capitare casi di spaccio, ma dalle nostre parti sono davvero situazioni più uniche che rare. Al contrario di quelli dell’est, i senegalesi rischiano di mettersi nei guai soprattutto con gli affitti. Di solito, in combutta con un italiano: quest’ultimo mette la casa, nomina padrone un Abu qualunque, sulla parola. Quindi l’Abu in questione chiama ad abitare là dentro le sue conoscenze, facendo pagare una quota minima. Quindici senegalesi riescono a vivere in sessanta metri quadri e con un solo bagno, senza problemi. Sono lavoratori, seppure della fascia più umile: il modo di mettere insieme duecento euro al mese lo trovano sempre. E così ecco che il tale appartamentino sfitto da millenni di colpo imbarca un tremila euro, alla zittina. Al Capocasa va una quota degli incassi. Il suo compito è accertarsi che tutti paghino puntualmente, e che la casa non si trasformi davvero in un letamaio. Mentre un mio onesto concittadino inveisce al bar contro gli immigrati che rubano il lavoro ai giovani. Ma solo per incassare i soldi di quei poveracci, cambiando una macchina ogni sei mesi.
Manlio è pronto per uscire. Prima di andare si sofferma, dice:
«Via dell’Unità. Diciannove».
Annuisco.
Il mio responsabile se ne resta ancora lì, sospeso, a guardare nel vuoto. Alla fine si scuote. «Senti, quando te ne vai, chiudi bene tutto».
Sul momento penso di trascorrere la giornata in pigiama, trascinandomi a stento tra il divano e il bagno. Poi mi rendo conto che non è proprio un bel modo per dare l’esordio al 2013. Così mi viene un’idea. Facendomi violenza comincio a cercare i vestiti. I pantaloni sono ancora umidi di qualcosa che non ricordo. Allora neanche me lo domando, e li infilo.
La parte più dura è tenere la parte del ragazzo tranquillo di fronte ai miei, che comunque non sono mica scemi: sono pallido come la morte. Ho delle macchie violacee intorno agli occhi.
Esco di casa. Nell’aria c’è quest’ottusità sorniona di fondo, quasi metallica, classica del primo giorno dell’anno. Cammino strascicando i piedi sul marciapiede. Ma d’un tratto mi fermo.
Ho di fronte uno dei miei manifesti. In alto, con font potente, c’è scritto GRAN MAGAL. Questa locandina ha appena una decina di giorni di vita, eppure già cade a pezzi. Leggo il riquadro laterale, che si è salvato a stento.
Magal è un termine wolof che significa “rendere omaggio”, “celebrare”. Nella comunità Murid esistono diversi Magal, ma il più importante è quello del diciotto del mese lunare di Safar: il GranMagal di Touba. In quell’occasione i praticanti commemorano il viaggio reale e spirituale di Cheikh Ahmadou Bamba. Nel giorno del Gran Magal circa tre milioni di fedeli, provenienti da ogni luogo, si riuniscono a Touba e in contemporanea in tutte le città del globo, in un momento di devozione spirituale collettiva. I khassaïd vibrano, mentre si recitano le salmodie scritte da Cheikh Ahmadou Bamba stesso, in onore e riconoscenza di Allah. Per i senegalesi celebrare il Gran Magal nelle città in cui vivono non è soltanto un modo per sentirsi in contatto con la propria comunità religiosa, ma anche la possibilità di un ritorno in patria e un pensiero libero da condizionamenti. Il Gran Magal è aperto a tutti.
Per mettere insieme queste informazioni ho dovuto saccheggiare un certo numero di portali web. Informazioni che Manlio non ha neanche letto, allungando sulla bozza del manifesto un’occhiata indifferente.
Ma la notizia che mi stuzzica è un’altra: il Gran Magal cade proprio oggi, primo giorno dell’anno. Che a quanto dicono i documenti di un certo numero di senegalesi, è anche il giorno in cui si festeggiano molti compleanni. Insomma, una congiunzione cosmica o qualcosa del genere. Che forse vale la pena di vedere.
Il pavimento dello stanzone è stato coperto da una miriade di tappeti. Entrando sono stato sul punto di tirare fuori il tesserino del Samarcanda, per farmi identificare. Ma alla porta c’era un gruppo di negroni intenti a parlare nella loro lingua, tutti festanti e pieni di risate. Di certo un po’ ubriachi. Appena mi hanno visto arrivare mi hanno detto: «Uolla, cumpà ». E si sono spostati, per farmi passare. Uno di loro mi ha chiesto di battere il cinque. Intanto mi facevo questa domanda primordiale: chissà per quale motivo gli extracomunitari imparano la parola “cumpà”, tra le prime.
Quel che mi ritrovo davanti è questo: i tappeti, appunto. E tanti senegalesi. Una torma da spavento. Uomini, donne, bambini scatenati. La lunga tavolata con i grandi calderoni, in cui chiunque va là, inzuppa la mano nuda nel riso, fabbricandosi delle polpette nel palmo. Odore di pesce, di cuoio, di deserto. Musica dagli altoparlanti, masterizzata male, tutta ovattata. Colpi di djembe un po’ da ovunque. E una moltitudine di chiacchiere. Neanche l’ombra di una bevanda alcolica. Nemmeno una lattina di birra chiara senza senso, di quelle che bevono i muratori.
Nessuno fa caso a me. Finché ho una scossa dentro: vedo Manlio, anche se sul momento penso di più a un’allucinazione. Se ne sta là, a pochi passi da me. Proprio nei pressi di uno dei tanti manifesti che sono stati appesi alle pareti dello stanzone.
Mi avvicino, stando attento a non calpestare qualche piatto di carta, qualche strumento che non ho mai visto prima. Manlio sta parlando con due ragazzi che forse hanno la mia età, forse il doppio, non lo capisco mai, ci sono senegalesi che dimostrano vent’anni anche a cinquanta. Sono sul punto di manifestarmi, ma ecco che un donnone si frappone tra me e il mio responsabile. Il donnone prende Manlio da dietro, lo abbraccia. Lui si volta. Bacia il donnone sulla bocca. Un istante dopo si sporge di lato. «Catone!», dice.
Non capisco se è più incazzato, imbarazzato o sorpreso. Ripete ancora: «Catone». E intanto si stacca dalla donna. Non so che dire. Manlio e io siamo gli unici visi pallidi all’interno dello stanzone. Finché lui fa questa cosa assurda: sorride. Poi, con una voce che neanche sembra la sua: «Hai fatto un manifesto spettacolare. È piaciuto a tutti». Dopo abbassa lo sguardo. In un nanosecondo diventa il solito stronzo di sempre. Dice: «Va’ a toglierti le scarpe, per favore».
Mi guardo attorno. Solo adesso mi accorgo che sono tutti a piedi nudi, compreso il mio responsabile. O forse me ne ero accorto, ma non lo avevo decifrato bene: solamente notando i piedi bianchi di Manlio mi sento davvero inopportuno. Come se vedere dei senegalesi scalzi fosse dato per scontato. E un po’ mi vergogno, perché alla fine è inutile girarci attorno: sono strapieno di sovrastrutture imbecilli. Tolgo le mie Nike sformate sfilandole con i calcagni, mi chino, le prendo su.
«Portale là», dice Manlio indicando uno sfacelo di scarpe nei pressi dell’entrata.
Annuisco, e subito m’incammino. Quando arrivo al punto di metterle giù, d’istinto ho la pulsione di posizionare le mie luride scarpe da ginnastica in un angolo, per riconoscerle bene, senza mischiarle. Ma poi ci ripenso.
Socchiudo di un niente gli occhi mentre le getto nel mucchio, lasciando che si mescolino con tutte le altre e basta.
Scopri le opportunità di Giovanisì per Servizio civile