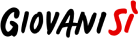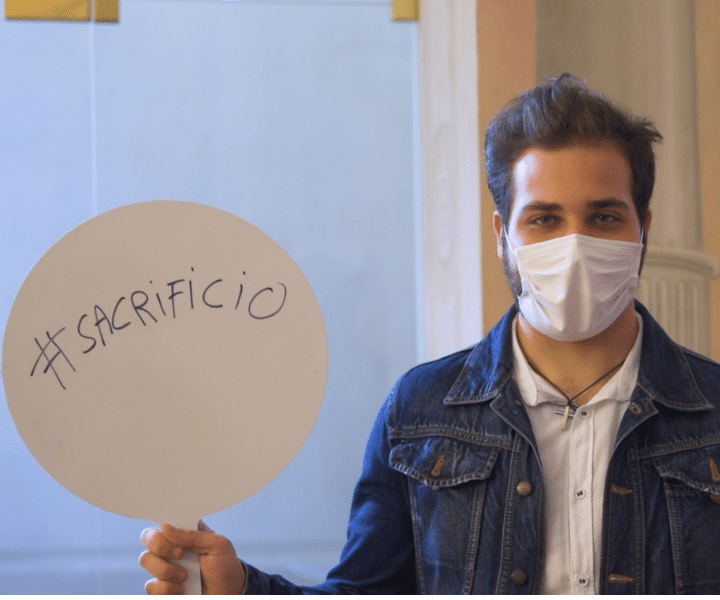Tre
Marco
Pubblicato il: 10 Ottobre 2013 08:13
Oggi, in Italia, circa il venti per cento degli studenti della scuola primaria incontra difficoltà nell’apprendimento del sistema dei numeri. Difficoltà spesso significative.
Adam è uno di questi.
Sembra anche che su una classe di venticinque ragazzi, sia altamente probabile che si verifichi la presenza di uno, se non addirittura due dislessici.
Adam è uno di questi.
È molto frequente che una specifica difficoltà dell’apprendimento venga individuata in ritardo. Ovvero, quando il bambino ha già subìto un discreto numero di insuccessi, scambiati per scarso impegno e disinteresse verso le materie trattate. I ripetuti fallimenti in ambito scolastico si ripercuoto sull’autostima del ragazzo in modo micidiale. In famiglia e in classe viene sgridato, spesso gli sono imposte “punizioni” che hanno lo scopo della disciplina. Non facendo altro che peggiorare la situazione, portando il bambino alla chiusura verso il mondo, a partire dalla famiglia.
Adam è discalculico.
Adam è dislessico.
Adam ha otto anni.
Ed è cinese.
Adam è diverso.
Tra i compiti per le vacanze di Natale, gli avevo assegnato quello di tenere una specie di piccolo diario su cui appuntare i fatti della giornata, anche quelli insignificanti.
Mi ha portato un foglio bianco. Allora gli ho chiesto perché. Lui mi ha risposto che le sue vacanze sono state tutte uguali. Adam quando parla non guarda mai negli occhi. Ha detto: «Mi sveglio. Vado al negozio. Mangio. Vado a dormire. Poi mi sveglio. Vado al negozio. Mangio…».
Gli ho chiesto come aveva trascorso tutti quei pomeriggi. La sua risposta è stata questa: «Gioco al computer. Poi mangio. Vado a dormire. Mi sveglio…».
Adam vive in Italia quasi da quando è nato. Non ha problemi con la lingua. I suoi genitori sono brave persone, gestiscono un grande capannone in zona industriale. Capannone che vende di tutto, dalle lampadine alle scarpe, dai tappetini per le auto al cibo per gli animali. I genitori di Adam sono benestanti. Vestono il loro figlio solo con abiti firmati.
Adam adesso è qui, tenta di mettere in colonna dei numeri. Se ne sta con un gomito puntato sul banco, la mano a coprire gran parte della faccia, come per oscurarsi dal resto della classe. Classe che nel frattempo assiste a una normale lezione di matematica, scornandosi con i primi rudimenti delle proporzioni.
Anche noi cambiamo materia quando la cambiano gli altri. Ma per Adam non c’è nessun mutamento nelle fattezze del professore: resto io. Questa è tra le tante cose che proprio non vogliono andargli giù. E che ribadiscono la sua diversità. A volte, se per caso posiziona i suoi occhietti neri nei miei, mi sembra di leggerci dentro così tanto odio che per un attimo sono io quello che deve spostare lo sguardo altrove.
Adam sembra spostarsi nel mondo come un sacco vuoto semovente. Gli dicono di camminare, e lui cammina. Gli dicono di mangiare, e lui mangia. Se nessuno gli rivolge la parola, Adam si spegne, semplicemente. Il suo sguardo si perde, le sue spalle si afflosciano. E se ne resta lì, parcheggiato, in attesa di un altro stimolo esterno.
Pare che Adam, a differenza dei ragazzini della sua età, abbia smesso di piangere. Non ci riesce più, neanche sotto la più feroce delle sfuriate. A prima vista potrebbe addirittura sembrare un placido bimbetto cinese dalla faccia cicciotta, in assoluta armonia col Tutto. Mentre dentro forse è mangiato dallo sprofondo costante.
A pensarci bene, è di Mara la colpa di tutto. Mi telefonò a un’ora assurda, in pieno giugno. «Sono arrivata in anticipo!», urlò facendomi scoppiare la testa. «Per piacere, vienimi a prendere ».
Mara è più di una cugina. Siamo nati lo stesso giorno dello stesso anno, come i gemelli. Lei da mio zio Marco, io da sua zia Chiara. Forse non c’è un altro caso così in tutto il mondo.
Erano appena le otto di una domenica mattina. Guardai la finestra: il vetro era squassato da un temporale tremendo. Un altro temporale mi rimbombava dentro, vista la baraonda festaiola della sera prima. «Arrivo», le dissi.
La trovai davanti alla stazione, al riparo della pensilina. Scesi, la aiutai a caricare i bagagli. Solo quando rientrai in macchina ci salutammo davvero, abbracciandoci un po’.
Ci fermammo al Caffè Davoli per fare colazione. Quello era il posto in cui da ragazzi abbiamo trascorso molte mattinate, quando fingevamo di prendere il treno per andare alle superiori. Ci rintanavamo lì, con la solita combriccola.
«No, non ce la faccio», disse dopo un po’ raccontandomi di lei. «Milano è una schifezza. Giuro che se restavo un’ora di più…». E insomma, l’avanscoperta cittadina si era conclusa così, miseramente, con un ritorno anticipato. «E poi un cazzo di lavoro lo trovo anche qui», concluse. Quindi, cambiando subito tono: «Ma dimmi di te!».
Fu in quel momento che me ne accorsi. Guardando alle spalle di Mara presi di mira una locandina, appiccicata al banco del bar. La parola “Bando” campeggiava a caratteri cubitali. C’era il logo della Regione. Quello della Provincia. E del Comune. Andai a guardare da vicino. La prima cosa che lessi, fu che scadeva il giorno dopo.
Ci provai, proprio in corner. Così, a cuor leggero, senza crederci tanto. Fu buffo quando arrivò la risposta: avevo vinto. La mia quasi laurea in Storia cominciava a dare i suoi frutti.
Attività di volontariato in biblioteca, per conto di un’associazione di Cecina. Attività rimborsata. Tutto questo, mentre nei giorni caldi dell’estate tutti si davano alla bisboccia totale, seppur lavorando la stagione nei bagni, nei locali che tiravano fino a notte fonda.
Io catalogavo libri. Mi occupavo dei dettagli per certi incontri d’intrattenimento culturale, ai quali partecipavano gruppi di bambini. C’erano famiglie che approfittavano degli eventi mattutini nella sala dei ragazzi, e allora d’un tratto la biblioteca si trasformava in una specie di asilo, venendo invasa dai mocciosi urlanti. Altri volontari si prendevano cura di loro, creando gruppi di lettura, di gioco. Fu lì che vidi per la prima volta Adam.
Lo portava Jo, la sua sorella maggiore. Diceva di abitare da anni a San Vincenzo, ma io non l’avevo mai vista prima.
Se tutti i genitori scaricavano i loro pargoli per darsi subito alla fuga, Jo restava. Per la sua famiglia quegli incontri non erano un modo per parcheggiare un figliolo da una parte per un paio d’ore, approfittandone per fare la spesa o prendendo un minimo di tintarella in spiaggia. Per la famiglia di Jo quegli incontri erano un modo per dare al loro figlio taciturno un po’ di compagnia, e magari degli stimoli che lo portassero a interagire con gli altri ragazzini.
Adam era il più grande di tutti. Di solito, mentre i suoi compagni si scagliavano subito sui libri parlanti e altri giochi intelligenti, lui sceglieva una sedia del piccolo tavolo colorato per bambini, e si metteva lì, senza fare niente.
Intanto Jo e io parlavamo. Improvvisamente eravamo gli unici della nostra età, chiusi in una stanza strapiena di pesti. A parte i volontari, che neanche avevano il tempo di respirare mentre tentavano di attirare l’attenzione dei bambini, che per contro correvano ovunque.
Jo mi parlava di Adam. Ma mi diceva anche qualcosa di sé, come per esempio il fatto che anche lei era cresciuta in Italia, ma appena si era presentata l’occasione, aveva preferito emigrare in Cina. Disse proprio così: emigrare. «Un conto è non vedere come funzionano le cose nel mondo », mi disse una mattina.
«Un conto è averle viste e ritrovarsi ad abitare qui. A sedici anni non c’è quasi nessuno che sappia parlare l’inglese. Ed è un miracolo se siete usciti due volte all’estero. La scuola è uno schifo. Il lavoro è uno schifo. In Italia a venticinque anni c’è gente che ancora si laurea. Altrove ci si sta già comprando una casa, volendo. E poi siete così…». Sorrise mentre diceva questo. Strinse gli occhi, quasi vergognandosi. «Così attaccati alla mamma». Dopo inscenò di essere attraversata da un brivido.
Neanche riuscii a chiederle di vederci, una sera. Ma osservandomi con lei, con il passare dei giorni Adam sembrò abituarsi a me. Si avvicinava. Dava persino l’idea di volermi salutare.
Quando i corsi estivi si chiusero, persi Jo, che sparì in mezzo al mondo, lasciandomi qui, con la mia quasi laurea. Che comunque bastò per farmi partecipare a un altro piccolo concorso, in vista dell’anno scolastico. Il bando parlava di un posto come insegnante di sostegno a tempo determinato.
Nel momento in cui il gippone del padre di Adam si ferma davanti ai cancelli della scuola, si voltano molte teste. Tutti i bambini restano ammaliati alla vista di quel mostro metallico, che anche ai miei occhi somiglia a un mammut, figuriamoci ai loro. Poi da quella bestia scende Adam, tutto imbacuccato. Si prende un bacio sulla testa e s’incammina verso l’entrata.
A volte provo a dirglielo, parlando piano: di salutarmi sua sorella, se di tanto in tanto gli capita di sentirla. Adam abbassa la faccia, neanche annuisce. Alza il ponte levatoio, arroccandosi nel silenzio.
Sono ormai due mesi che nell’ora di matematica affrontiamo questo solito esercizio: io disegno delle palline sul foglio. Quando mi fermo, dico ad Adam di scriverne il numero. Non vado mai oltre le sei.
Non è sempre facile. Adam ha questa cosa di non concepire la numerazione delle cose. Come se non bastasse, ha dei problemi a tradurre nella sua mente i simboli in segni di significato. La maggior parte delle volte spara sulla carta un numero a caso: se le palline sono tre, lui scrive un sei. Allora scuoto la testa, cerco di spiegargli la soluzione. Cancello, ne disegno di nuovo tre. Lui scrive cinque. Ripetiamo tutto da capo. Adam scrive uno.
È una cosa che alla fine consuma anche me. Cercare di spiegare il numero tre per delle ore può svuotarti dentro. Anche perché poi finiscono le parole, non c’è più un esempio sulla faccia della terra a cui tu possa appigliarti. Adam ha un grosso problema di apprendimento, tutto qui. Ma non è ritardato, anzi. Solo, non capisce i numeri. Non sa attribuire il giusto suono o significato alle parole scritte.
Disegno tre palline, per la milionesima volta. Gli dico di provare a toccarle con le dita, come gli ho appena fatto vedere, aprendone una dal pugno per ogni cerchietto.
Adam scrive un altro cinque.
Ci sono delle volte in cui fa addirittura un più.
«Cazzo», sbuffo sottovoce. Volto la pagina, disegno le tre palline.
Adam le osserva, muto. Sembra che si trovi al cospetto di un precipizio immondo.
«Su, riprova», dico. E un po’ mi pento del tono, si vede lontano un miglio che sto pulsando di rabbia e frustrazione.
Adam scrive uno.
Non sento storie: volto la pagina in malo modo.
Disegno tre palline.
«Conta», sibilo tra i denti. Eppure cerco di sorridere.
Adam comincia a tremare. Alla fine scrive un altro uno.
Volto la pagina. Ecco altre tre palline. Insieme, gli prendo il pugno. «Tira fuori un dito per ogni pallina», dico poggiandoglielo sulla carta. «Metticelo sopra. Contiamo ad alta voce».
Adam è diventato tutto rosso. A volte fa così. Tenta di ritrarsi, ma io lo tengo fermo con il pugno sulla pagina. «Su, è facile».
È un momento: Adam spalanca la bocca, e comincia a urlare con tutto il fiato che ha. E peggio: prende a scalciare, si divincola. Con i piedi urta il banco e lo rovescia.
Siamo tutti pietrificati. I bambini hanno gli occhi fuori dalle orbite. Intanto Adam si sgola, si dibatte, scuote la testa da una parte e dall’altra. Finisce il fiato. Inspira e ricomincia. Una vena enorme gli si disegna sulla fronte, trasformandogli il volto.
La signora Mazzotti prova a dire: «Oddio, proviamo a…».
Ma ancora, è un attimo: Adam chiude la bocca, torna il silenzio. Resta qui, accanto a me. Respira come dopo una corsa furibonda.
La porta dell’aula si spalanca, compare Paolo, il bidello. Dietro di lui si affaccendano subito le facce di Susanna Macii e Sergio Catani, forse di lezione nelle aule accanto. Tutti gli occhi sono su Adam, compresi i miei.
Per contro, il suo sguardo è talmente nuovo che per un momento mi sembra un altro ragazzino. Sembra essersi svegliato ora da un sogno orribile, e vividissimo. Ha la faccia di qualcuno che all’improvviso si è accorto di un fatto clamoroso. Di quelli che ti ridisegnano da capo nel mondo.
Tutti chiedono cosa è meglio fare: forse bisogna chiamare la famiglia. O portiamo il bambino nell’aula insegnanti e gli diamo una cosa calda? I suoi compagni di classe hanno già cominciato a sghignazzare, a fare battute cretine. Poi Adam fa questa cosa strana, inaspettata: si volta a guardarmi. Ha lo sguardo allarmato, sperso. Provo a sorridergli.
Ma lui si è accorto di esistere.
Adam ha capito che ha dei problemi.
D’un tratto si scaglia su di me, affonda la faccia contro il mio petto piangendo a dirotto. Alla vista di questo, la Mazzotti resta senza fiato. Poi comincia a singhiozzare anche lei, commossa. Ma è più forte il bisbiglio feroce dei ragazzini, che essendo ragazzini sono implacabili.
Prendo Adam, lo tiro su, sollevandolo da terra.
Lui non mi molla, continua a piangere a scroscio, affonda la sua faccia cicciottella contro l’incavo del mio collo. E io lo porto fuori, per fargli prendere un po’ d’aria fresca.
Scopri le opportunità di Giovanisì per Servizio Civile